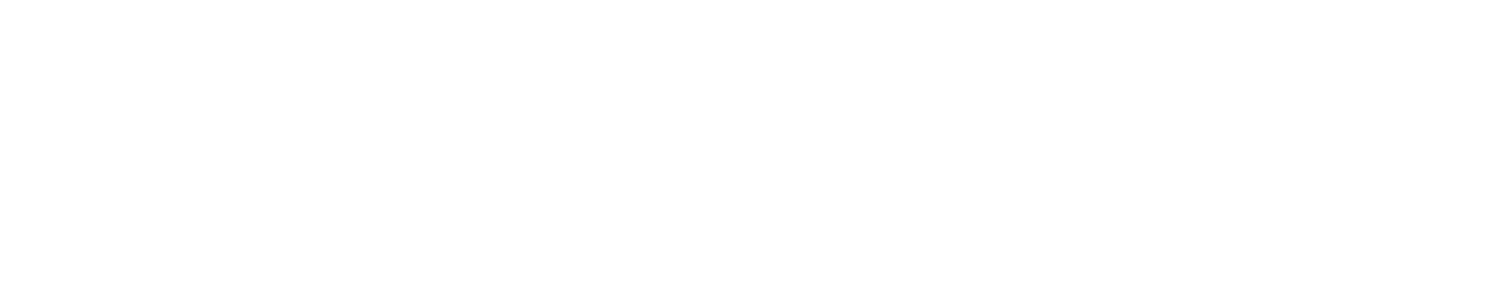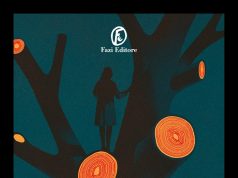Editore E/O – Collana Dal Mondo
Anno 2025
Genere Thriller
464 pagine – brossura e ebook
Traduzione di Giuseppe Giovanni Allegri
 Un giornalista riceve l’incarico di scrivere un reportage su cosa è successo ai quattro scienziati del Rapporto 21 a cinquant’anni dalla sua pubblicazione. Cosa fanno adesso, qualche aneddoto sul lavoro d’equipe a Berkeley o sul Nobel, dov’è finito Gudsonn, il genio della matematica dei quattro. Il rapporto consiste in nove scenari sul futuro della civiltà industriale basati su parametri come il consumo di alcune risorse naturali e la crescita della popolazione, elaborati da un computer.
Un giornalista riceve l’incarico di scrivere un reportage su cosa è successo ai quattro scienziati del Rapporto 21 a cinquant’anni dalla sua pubblicazione. Cosa fanno adesso, qualche aneddoto sul lavoro d’equipe a Berkeley o sul Nobel, dov’è finito Gudsonn, il genio della matematica dei quattro. Il rapporto consiste in nove scenari sul futuro della civiltà industriale basati su parametri come il consumo di alcune risorse naturali e la crescita della popolazione, elaborati da un computer.
Come è stata l’esistenza di chi ha visto che i dati sull’interazione tra la crescita umana e le risorse finite del sistema Terra portavano otto volte su nove a uno scenario in cui il treno della crescita sarebbe stato costretto, più o meno bruscamente, a rallentare.
E una nona simulazione in cui l’elaboratore elettronico proietta qualcosa di sorprendente, sconvolgente, orribile. Continuando così la musica avrebbe prima rallentato, poi si sarebbe interrotta: la popolazione umana e la crescita industriale intorno al 2050 avrebbe subito un brusco, repentino crollo. Il modello della crescita infinita in un pianeta finito avrebbe portato l’umanità al collasso e ai suoi orrori. Come hanno vissuto i “profeti” della dinamica dei sistemi, I quattro che predissero la fine del mondo, mentre il conto alla rovescia sembra continuamente scadere ma nessuno ha voluto o potuto fermare il treno del progresso.
All’epoca il libro era stato un best seller. Non era stato il primo dedicato all’emergenza ambientale, ma il rapporto 21 aveva, per primo, dato una visione panoramica e numerica del sistema-mondo. Per primo aveva dimostrato scientificamente l’impasse della crescita in un mondo finito. Era stato violentemente criticato. Terrificante leggere un libro vecchio di cinquant’anni che diceva già tutto.
Seguiamo il racconto dei coniugi Dundee, giovani studenti universitari nel 1973 che rispondono a un annuncio di lavoro del professor Stoddard, pioniere della dinamica dei sistemi con a disposizione un calcolatore elettronico IBM. I Dundee diventeranno dopo la pubblicazione il volto pubblico del team, girano il mondo incontrando artisti, intellettuali, partecipano a conferenze e feste. Sono quelli che diffondono i risultati della ricerca diventando incidentalmente attivisti per la causa ecologista. Diventano anche l’obiettivo della reazione alla “cattiva” novella. Pagina dopo pagina, si svolge il flusso del dibattito sul cambiamento climatico, gli ostacoli e la formazione di quel fronte che oggi afferma, dopo varie fasi di dileggio, sottovalutazione e negazione, che la degradazione dell’ambiente non sarebbe altro che il prezzo per il benessere e la civiltà tecnologica.
Quérillot invece, lontano dai riflettori, sceglie un’altra strada, quasi un protagonista tipico di un romanzo di Houellebecq, e gode delle gioie e delle opportunità che la civiltà ancora per qualche decennio può offrire. Altro bellissimo personaggio, a suo modo altrettanto brillante, per cui la negazione del futuro è comunque impossibile. La vita sentimentale, ripicche, invidie, vizi sono il colore e i dettagli di questi personaggi. Dialoghi e descrizioni sono interessanti, sfaccettati, vite normali che sono come inciampate rivelando qualcosa di grosso, tanto importante da avere l’apparenza di essere l’unica cosa importante davvero. Il Rapporto 21 è un momento di lucidità per i personaggi, la loro vita e quella di tutta la società umana sono il segno dei limiti di questa lucidità. E dei suoi pericoli. La scoperta della tana del Bianconiglio, in un’oscura chiarezza, è la vita di Gudsonn, il quarto di questi profeti. Le tracce del passaggio di Gudsonn in foreste e comunità, il suo diario, il mistero sul suo destino sono il momento migliore di un romanzo già coinvolgente, profondo.
La vita di Gudsonn incrocia con la vita, le parole e le azioni di Ted Kaczynski, altro genio della matematica, autore de La società industriale e il suo futuro ed ecoterrorista. Quello tra Gudsonn e Unabomber è un altro specchio narrativo eccellente. “La verità dei numeri è Altrove”, scrive Gudsonn mentre avanza verso quello che sembra un delirio psicotico, se folle è l’uomo mentre l’umanità avanza incosciente verso la fine della civiltà as we know it. I numeri se lasciano il mondo indifferente, in un conto alla rovescia troppo lontano alla sua scadenza per preoccupare, ha un effetto psicotico su altri: Godel, Unabomber, Gudsonn come vittime consapevoli di una qualche sequenza inumana nel mondo matematico, una pura verità che gli uomini possono percepire, comprendere, pagando con la vita.
Il prosciugarsi del sottosuolo e sai che è un processo irreversibile. Vedi cicli sempre più serrati che sono come tumori maligni intorno al cuore e il cuore che si imbizzarrisce sempre più velocemente. Cambia tutto. Non c’è più nulla di innocente. Dietro ogni oggetto ci sono tutta una sfilza di macchinari, trasporti, consumi di energia e tu te li raffiguri, ciascuno di loro. Immagini l’odissea di ogni oggetto importato, la nave container a Shanghai, la lunga traversata, i dock a San Francisco, i camion che sfrecciano sull’autostrada e di nuovo altri camion fino all’ipermercato di merda. È una conoscenza e una sensazione. Diventi matto, in realtà, e inizi a calcolare tutto, in maniera ossessiva.
Se al lettore e la lettrice la storia del Rapporto 21 e dei suoi autori suona familiare questo accade perché lo è. È il 1972, Donella e Dennis Meadows, Jørgen Randers e William Behrens pubblicano i risultati della loro ricerca sull’interazione tra la crescita umana e il pianeta Terra. Lo intitolano I limiti dello sviluppo e diventa subito un best seller. Alla storia degli autori de The Limits of Growth lo scrittore Abel Quentin si è infatti liberamente ispirato.
I quattro che predissero la fine del mondo è un grande romanzo. Un thriller pre-apocalittico in cui l’assassino è diffuso, la violenza in corso come l’acqua fredda per la rana nella pentola e l’orrore del collasso solo immaginato, sugli schermi, in altri libri, in luoghi lontani o ignorati dalla cronaca dei disastri innaturali. È la storia di una catastrofe lenta, incompresa, forse perché semplicemente non accettabile. Non un libro sul cambiamento climatico che rimane sullo sfondo degli eventi e della narrazione ma un romanzo sul divide tra vivere ed esistere nell’Antropocene, su un incolmabile divario tra sapienza e saggezza. Una ricerca sulle Cassandre, come se studiandone, osservandone la vita, si potesse svelare, e risolvere, una qualche tara cognitiva della specie. Romanzo di persone che portano il peso del mondo, futuri impossibili e interrotti, di numeri e capanne nella foresta, abitato da demoni ingannatori e angeli folli.
Aspettative alte per questa quasi non fiction novel. Scrittura, struttura, sottotesto, verticalità, tutte superate.
Antonio Vena
Lo scrittore:
Abel Quentin è un romanziere e avvocato. Dopo Sœur (selezione Prix Goncourt 2019) e Il Veggente d’Étampes (Prix de Flore, selezione Prix Goncourt e Prix Renaudot 2021), nel 2024 ha pubblicato I quattro che predissero la fine del mondo, con il quale ha vinto il Prix des Libraires Points-Nancy ed e arrivato in finale per il Prix Renaudot.