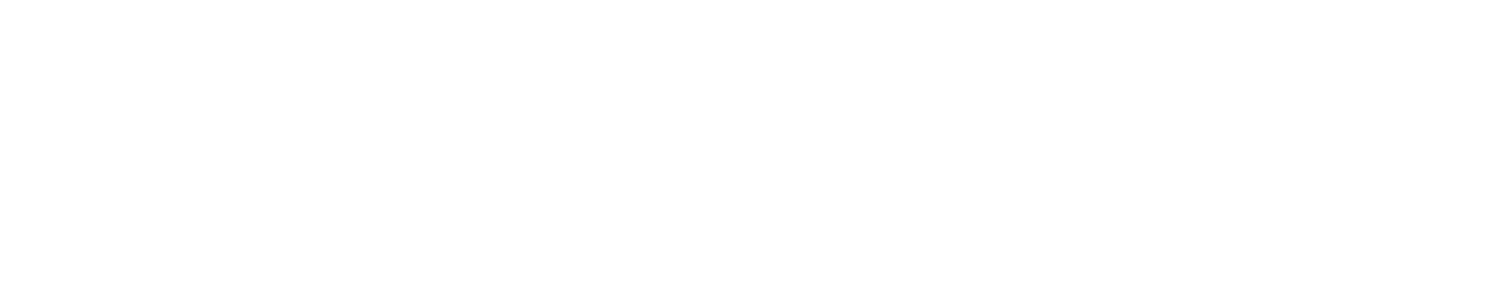[divider] [/divider]
Xiaolong Qiu, scrittore e traduttore, è nato a Shanghai e dal 1989 vive negli Stati Uniti, dove insegna letteratura cinese alla Washington University di Saint Louis. Oltre alle inchieste dell’ispettore Chen, pubblicate in trenta paesi, già adattate per una popolare serie radiofonica della Bbc e presto anche per una serie televisiva, di Qiu Marsilio ha pubblicato i due romanzi che raccontano le storie del Vicolo della Polvere Rossa e una raccolta di poesie dedicate a Chen Cao.
www.qiuxiaolong.com/
Lo abbiamo intervistato per farci raccontare qualcosa di lui e dei suoi romanzi. L’ultimo giallo si intitola L’ultimo respiro del drago, uscito da poco sempre per Marsilio, nella collana Farfalle/I gialli.
1. “L’ultimo respiro del Drago” è l’undicesima avventura con protagonista Chen Cao, come è cambiato il suo protagonista lungo tutti questi romanzi?
Q.: In origine non avevo programmato di scrivere una crime novel, ma semplicemente un libro sulla società cinese e sul livello culturale. Siccome era la prima volta che mi accingevo a scrivere un romanzo, mi sono reso conto di non avere idea di come strutturarlo. Allora mi sono rivolto al genere giallo, perché mi sembrava più semplice come struttura, un inizio, un’indagine e una fine. Quindi il personaggio principale è diventato un poliziotto, però è rimasto un uomo intellettualmente stimolato, che non si ferma solo all’indagine ma approfondisce anche l’aspetto sociologico e culturale. Negli anni, il mio personaggio è cambiato: nei primi due romanzi è un idealista, ottimista, crede davvero che la Cina stia evolvendo. A quell’epoca, la maggior parte delle persone lo credeva, anche tutto il resto del mondo, compresa l’Europa, pensava che con il cambiamento della politica economica sarebbe cambiato anche il Paese. Purtroppo, il sistema politico non è cambiato, di conseguenza il nostro poliziotto è diventato sempre più pessimista, disilluso e le sue posizioni lo mettono sempre nei guai.
2. In Cina ci sono due realtà distinte, il Partito ed il popolo, qual è il rapporto dell’ispettore capo Chen con questi due mondi?
Q.: Il fatto è che in Cina non c’è libertà di parola e di stampa e la maggior parte della popolazione, pur non essendo d’accordo, non ha la libertà di scegliere. Sappiamo che chi va contro il governo, finisce male.
Questa differenza tra governo e popolo esiste da sempre. Qualche anno fa ci fu un dibattito nel quale la domanda era: “E’ più importante la legge o il partito politico?” In realtà non può esserci indipendenza dal punto di vista legale, perché i giudici ascoltano i partiti. Alla fine, la risposta che uscì sui giornali fu: “La domanda è sbagliata.” Quindi, se vuoi farti queste domande, alla fine la risposta è che la domanda è sbagliata!
3. Nel romanzo “Le lacrime del lago Tai” aveva già affrontato la tematica noir del problema inquinamento in Cina. Come è cambiata la situazione in questi 5 anni?
Q.: Se parliamo di quel particolare lago, la situazione è un po’ migliorata. Quanto meno, il governo ne è al corrente e dice che se ne sta occupando. Nello specifico, i fiumi e i laghi sono molto inquinati, quindi non c’è stato un grande cambiamento. Non essendoci un partito di opposizione, in Cina non si affronta il problema e se lo fai succedono i guai. Tanto è vero che nel libro Le lacrime del lago Tai, ho parlato di un personaggio dal quale ho preso spunto dalla realtà, che aveva provato a pubblicare on line degli articoli su questa tematica ed è stato messo in prigione.
Quando dovevo pubblicare in Inghilterra, avevo pensato di aggiungere nome e cognome di questa persona, ma mi hanno suggerito di parlarne senza citare chi fosse, perché avrei potuto peggiorare la situazione. C’è un modo di dire in Cina, chiamato “Olimpic blue”, perché quando ci sono le olimpiadi, vengono chiuse le fabbriche e il cielo è pulito e terso. Poi, finiti i giochi, torna tutto come prima.
4. Cina e USA sono i paesi più potenti ed industrializzati al mondo. Stanno forse sottovalutando la tematica ambientale o sono vittime di altri meccanismi, come un’irrefrenabile sviluppo industriale?
Q.: In America ci sono due partiti contrapposti, con Trump che dice che non esiste l’inquinamento, mentre i democratici sono più aperti. In Cina magari ne parlano un paio di giorni, poi cade tutto nel silenzio. In realtà, ci sarebbero delle regole che le aziende devono rispettare in merito all’ambiente, ma non lo fanno. L’unica legittimità che il governo ha è il fatto che mantiene una crescita economica proprio grazie a tutto quello che c’è. E se cominciassero a occuparsi di mettere a norma tutto il sistema industriale, significherebbe una crescita inferiore e andare a contraddire tutto quello che il governo sostiene, cioè che la Cina è una potenza.
 5. L’ispettore capo Chen è anche un poeta. Come lei, tra l’altro. Ribellione di una vittima della Rivoluzione culturale?
5. L’ispettore capo Chen è anche un poeta. Come lei, tra l’altro. Ribellione di una vittima della Rivoluzione culturale?
Q.: Si, per lui scrivere poesie è un modo per trovare sollievo alle brutture del mondo esterno. Lo aiuta, perché non è solo un poliziotto tradizionale, ma attraverso le poesie gli piace approfondire l’aspetto psicologico e umano, anche del criminale stesso. Questo a volte lo manda in conflitto con se stesso, perché non dovrebbe essere in sintonia con il criminale, ma a lui piace capire i motivi che possono esserci dietro un omicidio.
6. Abbiamo conosciuto Shanshan, comparso prima nel romanzo “Le lacrime del lago Tai”, presenza forte e fondamentale anche in questo romanzo. Ci racconta come nasce questo personaggio caparbio e idealista?
Q.: E’ sicuramente diverso, un intellettuale. In questo romanzo è basato su una giornalista, un personaggio reale, che si chiama Chai Jing. Questa donna ha girato un documentario “Under the dome”, dove racconta l’inquinamento atmosferico e ci si domanda come il governo non abbia fermato la proiezione del video, che si trova comunque su internet. Nel giro di pochissimo ha avuto milioni di visualizzazioni, anche se nel giro di alcuni giorni è stato bannato. Non penso sia stata messa in prigione, ma ora difficilmente si trovano suoi articoli on line, come se fosse sparita dalla circolazione.
7. A proposito di questa relazione tra Cina e internet, quanto i cinesi possono confrontarsi con altri Paesi on line? Come fa il governo ad arginare questa voglia di informazione che può avere il popolo? Certamente non possono mettere tutti in prigione!
Q.: Il governo paga la polizia, che in rete controlla tutto il tempo quello che la gente scrive, bannando subito gli articoli che vanno contro il sistema. C’è una specie di sottobosco, tipo le VPN, indirizzi tramite i quali si riesce a passare le informazioni. Tempo fa andai ad un convegno, nel quale mi suggerirono di procurarmi una VPN personale, perché non avrei neanche potuto controllare le mail.
Abbiamo anche una sorta di Whatsapp, avevo scritto un articolo che mi hanno subito cancellato. C’è un modo di dire: “Hai avuto una tazza di the?” che in gergo significa: “Hai ricevuto un avviso di stare attento a quello che scrivi.”
8. Shanghai è un’altra grande protagonista dei suoi romanzi oltre a Chen. Cos’è Shangai per Qiu Xiaolong?
Q.: Sono nato a Shangai, è la mia città. Ci sono molto affezionato e, tutto sommato, fra tutte le città cinesi è quella più cosmopolita, aperta a tutte le altre realtà. Allo stesso tempo, si creano conflitti ideologici perché arrivano influenze da tutto il resto del mondo.
Un segnale positivo è che c’è un festival di letteratura internazionale, organizzato da una ricca signora australiana, dove cogli le influenze da tutti i paesi del mondo.
9. In una recente intervista, lei ha dichiarato: “Quando in Cina bruciavano i libri, noi li facevamo circolare di nascosto.” Mi ha ricordato il famoso libro di Ray Bradbury, “Farenheit 451”. Riusciremo mai a evolverci o rimarremo sempre in un limbo dove cerchiamo di proteggerci da questa mano della dittatura che coinvolge tanti paesi?
Q.: Certo in Italia non possiamo paragonarci alla Cina…
Riesco sì, a vedere la luce, anche se il governo cinese è così potente che neanche ci immaginiamo. Ha cambiato la costituzione, prima il governo aveva due mandati e ora ne ha uno con un termine indefinito, come fosse un impero. Se ci sono degli intellettuali che esprimono un dissenso, vengono fermati. Anche se, con questi accordi (o disaccordi) di mercato con l’America, l’economia comincia a traballare. La gente non fa più finta di essere totalmente d’accordo, ma almeno la metà della popolazione pensa che il potere dell’America può farli uscire dalla dittatura.
Intervista a cura di Cecilia Lavopa