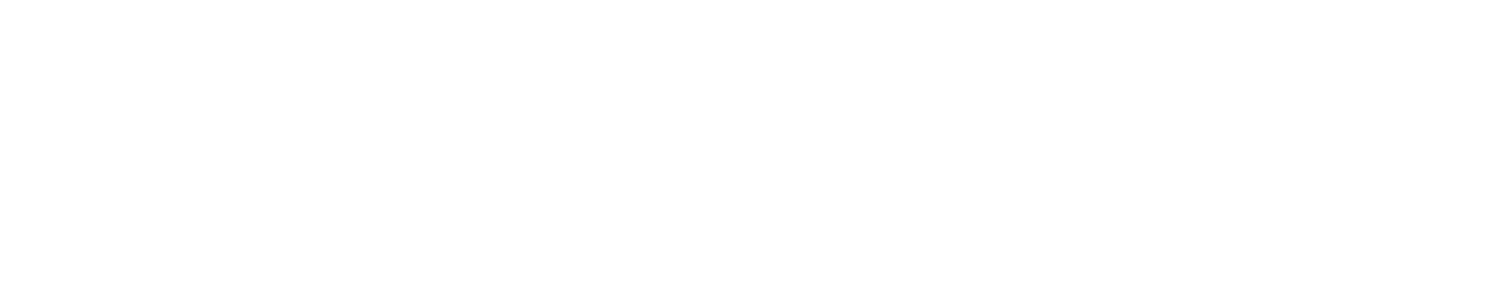[divider] [/divider]
Ho voluto esordire con un piccolo video che ho realizzato nei confronti di Maurizio de Giovanni, che legge un pezzo dell’ultimo romanzo, “Il purgatorio dell’Angelo”, appena pubblicato da Einaudi. Penultima puntata del commissario Ricciardi, lo abbiamo incontrato in libreria per farci raccontare – in una mini intervista – qualche curiosità sul libro e sul futuro del beniamino tanto amato dai lettori.
1. Ci sono lettori che stanno già piangendo per la fine della serie del commissario Ricciardi…
M.: Tremo al pensiero di come andrà a finire, ma è una storia, e io posso solo raccontarla. L’ultimo capitolo di questo romanzo si svolgerà nel mese di giugno del 1934, praticamente dopo un anno dalla storia precedente. Per la prima volta c’è una distanza così evidente tra una storia e l’altra e sarà nella settimana della notte dei lunghi coltelli. Troveremo di nuovo Manfred – l’ufficiale nazista che aveva chiesto la mano di Enrica – Falco, Ricciardi ed Enrica, Lidia. Il ragionamento che stiamo facendo in questi giorni con i ragazzi di Einaudi è che, dopo l’uscita dell’ultimo romanzo di Ricciardi, vorrei far uscire una raccolta di racconti con Bambinella come voce narrante che, nel suo modo pettegolo, ci descrive tutti i personaggi e le strade da loro percorse dopo.
2.In questo romanzo hai regalato molto al personaggio di Maione. Ce ne vuoi parlare?
M.: Questo libro ha avuto un percorso particolare… Non avevo mai parlato in undici romanzi degli effetti su Maione della morte del figlio. Mi ero sempre soffermato sulla moglie, ma non su di lui. Perché un padre, ancorché in maniera diversa, sopporta tantissimo della perdita del figlio. Volevo dare questo taglio: che tipo di elaborazione ha di questo lutto tre anni dopo? Prevaleva il sentirsi in colpa, perché faceva il suo lavoro? Prevaleva il cercarlo di nuovo? Ho voluto creare questa storia parallela.
3. Mi piace molto la similitudine tra Ricciardi che deve convivere con i morti mentre Maione, al contrario, vuole mantenere vivo il ricordo del figlio, che invece si allontana. Ce ne vuoi parlare?
M.: Ricciardi e Maione da sempre sono due facce – opposte – della stessa funzione. Maione è un uomo sentimentale, ma pratico, pragmatico. Ha molti valori, ma pochi punti fermi della sua vita. Ricciardi, al contrario, non pragmatico, vive in un mondo tutto suo, però non è sentimentale, non si concede perché ne vede gli effetti. Sono fuori squadra tutti e due. Maione capisce che Ricciardi ha qualcosa, è molto sensibile, non può sfuggirgli, ma si ferma prima.
E’ una caratteristica della mia città: ci fermiamo davanti al magico, accettandolo. Senza farci domande, da noi i morti e i vivi convivono stabilmente. Dico spesso che molti morti non sanno di essere morti e molti vivi non sanno di essere vivi. Si rincorrono, si incontrano, interagiscono in uno spazio ristretto, senza perdere la propria identità.
A Maione e Ricciardi succede la stessa cosa, perciò si vogliono bene, per questo sono affini e fortemente connessi, perché uno è il completamento dell’altro. Modo è amico di Ricciardi, ma Maione gli è fedele, sono sentimenti molto diversi.
 4. Mi ha colpito la dicotomia tra angeli e dannati, ma anche tra sacro e profano. Si mescolano religiosità e credenze e, quindi, da un lato ci sono i fedeli che si confessano per ambire al Paradiso come fosse un premio, poi ci sono gli uomini che vogliono togliersi un peso dalla coscienza. Ma qual è il vero Purgatorio?
4. Mi ha colpito la dicotomia tra angeli e dannati, ma anche tra sacro e profano. Si mescolano religiosità e credenze e, quindi, da un lato ci sono i fedeli che si confessano per ambire al Paradiso come fosse un premio, poi ci sono gli uomini che vogliono togliersi un peso dalla coscienza. Ma qual è il vero Purgatorio?
M.: La religione è uno degli aspetti più difficili da raccontare quando parli degli anni ’30, perché è difficile capire oggi quanto fosse importante, concreta e quotidiana, era un enorme fattore sociale. I preti e le suore erano tantissimi, operavano all’interno del mondo con una funzione così forte che oggi ci risulta incomprensibile. La messa delle sei di mattina era piena fino a fuori da ogni chiesa, chiunque prima di andare a lavorare ci andava. I preti avevano un ruolo sociale fondamentale, non c’era comunità che non avesse un prete, non c’era realtà che non facesse costantemente riferimento a un religioso. I preti e i militari erano tantissimi. Definire questi contesti significa dover spiegare molto di quell’epoca non lasciando niente per scontato.
La confessione, che è l’elemento che viene individuato sia in maniera religiosa che in maniera laica, era una realtà costante con la quale aveva un rapporto tutti. Il perdono è una riparazione, ma non una cancellazione. La colpa rimane e si duplica, perché quando io confesso la mia colpa a te, siamo in due a soffrire. E questo è un aspetto molto importante dal punto di vista narrativo. Religione, crimine, tutto finisce con una confessione. E spesso è una confessione sorprendente, come in questo caso, non tanto per il personaggio che la fa, ma per il motivo per cui l’ha fatto. Così come in Sara al tramonto, sorprendente è il motivo, che non è una vendetta, ma una terribile, atroce assoluzione. Poi c’è l’aspetto fondamentale, che aspettiamo da undici romanzi, che è il punto d’arrivo della confessione di Ricciardi a Enrica. Deve decidere se correre il rischio – enorme, grave – di essere riconosciuto pazzo dalla donna che ama. Non è questione di sentirsi dire un no, ma di mettere a conoscenza per la prima volta un altro essere umano di quella che lui è assolutamente convinto essere una follia, la stessa che ha portato la madre a morirne.
Andare incontro alla decisione se rivelare o no a Enrica questo segreto, è tutto per lui. Un doloroso percorso, ma necessario. Il Purgatorio è l’unico posto nel quale gli angeli non ci sono.
5. Dalla tua storia emerge che Maria, la madre di Enrica, è una donna terribile! Perché renderla così cattiva? In poche righe sei riuscito a caratterizzarla in maniera egregia, da commedia dell’arte!
M.: Nell’ottica del periodo, Maria è una madre assolutamente normale… Questa donna emerge da una ricerca per essere consona all’epoca in cui si svolge il romanzo, è una donna animata da buoni principi. Lascia stare che dal nostro moderno punto di vista è manipolatrice, violenta, ma opera a fin di bene. Lei vede quest’uomo ancora solo a trentatré anni, che poteva passare per una persona con problemi.
Pensa un po’ a come lo interpreta: non particolarmente abbiente, sempre con lo stesso vestito, vive senza famiglia con una governante, in un appartamento tutto sommato spoglio; fa il commissario di polizia, che per l’epoca era un ruolo anche a contatto con i criminali, quindi non era né un facoltoso commerciante né un aristocratico. Non porta neanche il cappello, quindi è anche irrispettoso. Quindi lei opera, nella sua maniera distorta, a fin di bene. Non è una cosa da poco. Sembra pessima, ma in realtà non è cattiva, è una madre che vuole sistemare la propria figlia. Il padre la vuole felice, ma è debole, dolce. Avendo già Enrica ben venticinque anni, Maria ha paura che resti zitella.
6. Come te lo immagini fisicamente Ricciardi, in un’eventuale trasposizione cinematografica?
M.: Lo vedo come Andy García del padrino parte III, però con gli occhi verdi. Il García de Gli Intoccabili. Non bello, viso affilato, di statura media. Non lo volevo affascinante. Quando l’ho immaginato, volevo che l’unica cosa notevole fossero gli occhi, perché sono quelli che rappresentano l’interno, una finestra sull’anima.
Articolo a cura di Cecilia Lavopa