
[divider] [/divider]
A Tempo di Libri abbiamo incontrato Mirko Zilahy: scrittore, giornalista e pubblicista. Editor per Minimum fax, nonché traduttore letterario dall’inglese (ha tradotto, tra gli altri, il premio Pulitzer 2014 Il cardellino di Donna Tartt). È così che si uccide, il romanzo con cui ha esordito nel 2016 facendo conoscere ai lettori il personaggio di Enrico Mancini, è stato un grande successo di pubblico e di critica ed è uscito nei principali Paesi esteri, fra cui Germania, Spagna e Francia.
Torna ora con il secondo romanzo, La forma del buio, Longanesi e gli abbiamo fatto qualche domanda.
1. Ciao Mirko e bentornato sul nostro blog. Ti intervistammo in occasione del tuo romanzo “E’ così che si uccide” (Longanesi, 2016) e alla domanda: “Chi è Mirko Zilahy?” rispondesti: “Se sapessi chi sono smetterei di scrivere! C’è una schiera di persone che mi affolla.” Ora, a distanza di un anno, hai fatto ordine?
M.: No, non ho messo ordine e tra l’altro questi libri sono il sintomo di questa continua alternanza di voci perché in “E’ così che si uccide” c’era una parte più rabbiosa, più ferita, dolorosa, delusa e ho fatto un libro molto nero e potente. Adesso è venuta fuori una parte più infantile, del visionario. Ho sempre avuto in testa questa idea di scrivere che mi ricordasse le atmosfere di Blake, autori romantici inglesi che mi piacciono molto, perché non è vero che il thriller nasce nel contemporaneo, bisognerebbe tornare indietro a leggere i classici.
Nel terzo che sto scrivendo ora c’è il concetto di identità e c’è una folla dentro ognuno di noi che spinge per dire la propria. Come nel film Split, un caso vero di un serial killer americano che era abitato da 23 personalità radicate talmente forti che anche la fisiologia cambiava. Uno di questi aveva il diabete e nel periodo in cui si trasformava in quella personalità aveva davvero problemi di salute. Convivo con le voci dentro di me: sono un padre amorevole, un tifoso della Roma becero e iroso. Scrivo, leggo e tento di essere autoironico e di divertirmi il più possibile.
2. Ritorna Enrico Mancini con questo nuovo thriller intitolato “La forma del buio” per Longanesi. Come ti è nata l’idea?
M.: In realtà dall’inizio avevo già in testa una storia di un migliaio di pagine che ho pensato di dividere in tre temi fondamentali e con un protagonista. Enrico Mancini ha perso la moglie di un brutto male e ha elaborato il lutto in modo orribile. Affronta la propria vita come un disadattato, indossa dei guanti che lo tengono lontano dal contatto degli altri. Al momento mi ricordava da vicino il senso della giustizia e della disumanità. Mi sono chiesto: Cos’è giusto? La legge di Dio, degli uomini, dello Stato o delle forze dell’ordine? O quello che ognuno di noi ha dentro il cuore? Finisco il romanzo senza una risposta: non c’è un nero o un bianco, non c’è un colpevole. Volevo tenere aperta una porta, nella letteratura non si devono dare risposte secondo me.
Nel secondo romanzo il tema che tratto è il rapporto con la realtà e con la trasformazione. Mancini ha capito che qualcosa sta cambiando dentro di sé, non è più fresco di lutto. L’immagine della moglie, il timbro della voce, gli odori, piano piano stanno scemando. Ma questi fenomeni gli fanno paura e lo fanno sentire in colpa. Ha bisogno della vita, si trasforma, però perde i fantasmi che ha lasciato nel buio. Lo stesso serial killer è legato al discorso della visione e del rapporto con la realtà e della trasformazione. Secondo Jung, la realtà non esiste, è la nostra psiche che la crea. Io ho estremizzato il concetto e ho creato un serial killer il cui fulcro problematico fosse quello del rapporto con la realtà, le allucinazioni e le visioni. Se pensi al mondo reale, alle regole e alla società, ti viene in mente quanto l’infanzia ne fosse completamente avulsa. Quindi ho pensato di attingere da quel periodo, un terreno comune su cui far nascere i mostri di cui parlo.
 3. Trasfigurare le vittime da parte dell’assassino è come aver dato grazia alla morte? Ma può averne?
3. Trasfigurare le vittime da parte dell’assassino è come aver dato grazia alla morte? Ma può averne?
M.: Io tento di costruire i miei corsivi in modo che siano come delle opere liriche, che abbiano una lingua più costruita, inconsueta. Come ad esempio la sirena e il canto della Callas. L’inesorabile bellezza della morte, queste voci cristalline, potenti, che raccontano delle storie tragiche. Io uso un linguaggio fuori dal thriller tradizionale, ho bisogno di raccontare la morte così forte, la disumanità di quel momento e la perfezione della bellezza. E’ un modo per costruire una storia e per dare la percezione del dispiacere e del dolore nei confronti dei lettori.
4. L’ombra e il buio sono i protagonisti dei tuoi romanzi. Due aspetti che richiamano alla paura e alla assenza di percezione visiva di ciò che ci circonda. Siamo ciechi, in fondo? Dammi una tua versione.
M. Il buio di questo libro è la base su cui crescono le paure di ciascuno di noi. Questo buio è il pozzo da cui ognuno dà forma alle proprie paure, soprattutto nell’infanzia. In questo libro ci sono i mostri. Roma è la città delle ombre, c’è un sopra e un sotto. E’ una città immobile, burocratizzata anche se non funziona neanche la burocrazia. Giri sempre per ritrovarti allo stesso punto. E’ una gloria che non esiste più. E’ un eco di spettri. Secondo me c’è una sorta di cataratta, i romani non vedono le bruttezze, c’è la sovraesposizione all’arte. Ci facciamo la foto davanti al Colosseo quando in realtà ci sono morte migliaia di persone. Quindi vediamo solo quello che ci va di vedere, non ragioniamo con i sensi nascosti, ma solo con la vista che è il più fallace. Ecco perché io costruisco i miei libri sulle parole, sui suoni, sulla scansione ritmica, perché mi serve a bypassare le immagini forti.
5. Mancini ha perso la moglie e fa fatica a lasciare andare il suo ricordo. Un libro quando è finito è come se fosse morto. Come saluti i tuoi libri quando li concludi?
M.: Il primo l’ho salutato con grande sollievo, poi in realtà con un senso di colpa fortissimo, per aver messo dentro molta cattiveria, molta rabbia e molta esperienza personale. Chi mi conosce sa che lo sentivo giusto, le persone sono esistite veramente, il massimo della disumanità nei confronti di una persona che amavo. Poi ho messo dentro le scene più dolorose della mia vita, quelle che mi hanno cambiato.
Con questo secondo romanzo ho fatto una fatica intellettiva, sono tornato ai classici della letteratura e ci ho lavorato tantissimo, ci ho messo mesi. Il primo è il libro del dolore, il 100% dei feed back dei miei lettori più o meno tecnici, dai librai ai lettori di genere, sono stati concordi nel dire che il secondo è meglio del primo. Mi piace molto la confezione grafica, mi somiglia molto, sono contento del lavoro che ho fatto.
Tra l’altro, la trasformazione è avvenuta anche dentro di me e ora mi sento geloso del primo. Il primo è Mirko Zilahy con tutto quello che mi ha dato la possibilità di scrivere e avevo bisogno di rappresentare la morte con un thriller.
6. I personaggi mitologici che sembrano rivivere attraverso la morte di poveri innocenti. Una sorta di rinascita per loro? Fanno ancora paura?
M.: Nel primo libro, dal mio punto di vista e del serial killer c’erano dei colpevoli e una giustizia da portare a compimento. In questo romanzo non ci sono colpevoli, ma vittime nel senso morale del termine. Ci sono innocenti che hanno la sfortuna di trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato. Hanno qualcosa che li accomuna all’universo immaginario del serial killer, in maniera molto frontale, molto grammaticale. Lui ha una sola prospettiva, legge Scilla, è la Sirena. Sono solo degli innocenti che hanno una vita simbolica letta dall’assassino. Il killer scrive, racconta la propria storia sul corpo delle proprie vittime e il profiler fa il lettore.
7. Come si fa a rendere i luoghi e i ricordi di un bambino da qualcosa di ludico – quindi lo zoo e il Luna Park – in qualcosa di terribile in cui ambientare la scena del crimine?
M.: Tutto ha una doppia faccia, un’ombra. I luoghi delle domeniche pomeriggio assolate a giocare a pallone da bambino, diventano spaventosi, non solo per la conformazione dei boschi e dei parchi. Il parco ha una connotazione ludica e tutti i giochi hanno il loro doppio. Lo zoo in sé è una grande prigione, ad esempio. Io stesso quando ci andavo avevo un’espressione di meraviglia – che ancora ho quando porto i miei figli – ma contemporaneamente di colpevolezza, melanconia. Così il Luna Park, non era rassicurante, era un posto sinistro con urla e odori che si sommavano. Nessuno è se stesso: il giostraio, i genitori, i bambini. Quando si usciva era un sollievo lasciare i mostri e le mie paure lì dentro.
8. Nella precedente intervista, mi dicesti che il secondo romanzo doveva intitolarsi Spettri. E’ così?
M.: Si, doveva essere il nome della mia trilogia degli spettri, perché Roma è una città spettro. Perché ho scelto il Gazometro per le connotazioni di spettro: l’acciaio, i parchi di Roma perché i miei personaggi, il serial killer, sono spettro e specchio. Sono persone che non vivono, figure che hanno delle esistenze spettrali, lo stesso Mancini sta passando da uno stato solido a un altro. In E’ “così che si uccide” iniziava sopra l’alto della figura d’acciaio e finiva con sotto – la pioggia che cadeva. Mentre ne “La forma del buio” comincia con “Al centro del cancello arrugginito” e finisce con “Nel cuore delle tenebre”. C’è la sospensione dello stato. Il terzo avrà un movimento ascendente. Tutti e tre cominciano con tre endecasillabi che sono la chiave di volta per entrare nel mondo delle favole, nell’inferno, il paradiso o il purgatorio. Noi italiani abbiamo l’esametro e l’endecasillabo come versi genetici, dalla poesia, alla musica.
Il terzo sarà una sorpresa.
9. Riprendo il titolo del romanzo, “La forma del buio”. Quale forma ha il buio e quale le parole?
M.: Il buio sono le mie paure, della morte. Adesso ancora più degli altri. Il male per me è il dolore, la sofferenza. Le parole in realtà sono un vano tentativo di dare un ordine all’universo. Di dare un ordine che dura il tempo di una vita, con un universo personale e autoreferenziale. Le parole sono le barriere contro il mondo, il primo modo per dividere il dentro dal fuori.
Intervista a cura di Cecilia Lavopa
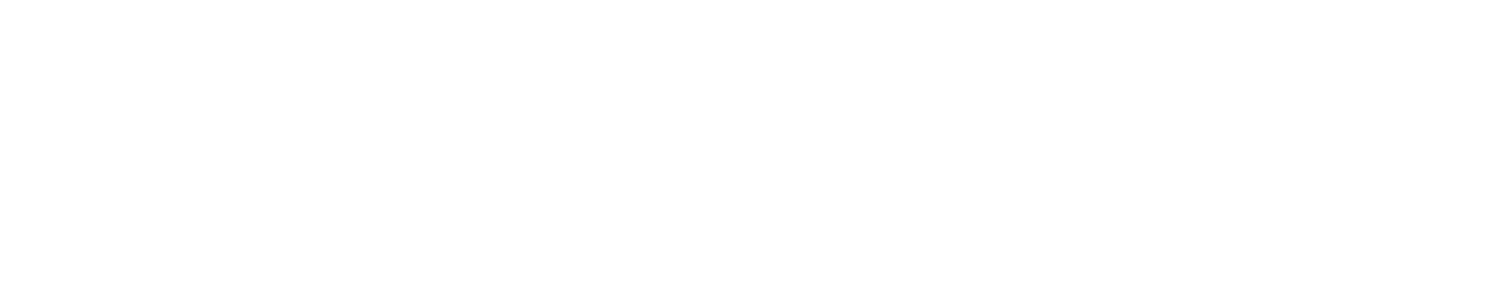













Devi effettuare l'accesso per postare un commento.