
[divider] [/divider]
Patrick Manoukian, alias Ian Manook, ha cominciato a scrivere a quindici anni e si è mantenuto agli studi, è stato corrispondente del giornale locale di Parigi. Giornalista, editore, romanziere e grande viaggiatore, vive a Parigi. Ha esordito con Yeruldelgger, Morte nella steppa, pubblicato da Fazi Editore nel 2016, primo capitolo di una trilogia con lo stesso protagonista cui segue Yeruldelgger, Tempi selvaggi. Pluripremiato e adorato dai lettori e dalla critica, Yeruldelgger è un vero e proprio fenomeno.
Lo abbiamo incontrato in casa editrice insieme ad altri blogger per farci raccontare di lui e dei suoi romanzi. Scrive ogni giorno storie che non ha mai finito, ma il futuro di questo scrittore ci riserva molte sorprese. Ecco cosa ci ha raccontato.
1. Tre romanzi ambientati in Mongolia, nei quali la descrizione del territorio è molto forte e preponderante. Come è riuscito a non ripetersi?
I.: Ho scritto i primi due insieme, il primo in estate e il secondo in inverno. I primi due li ho scritti per me e per i lettori, il terzo per il protagonista Yeruldelgger. Con il terzo sono tornato all’estate, ma in un ambiente differente: il deserto dei Gobi. Sono libri molto diversi tra loro, ma la Mongolia è la stessa.
2. I romanzi con protagonista Yeruldelgger hanno come sottofondo il tema sociale, mettendo in luce la nuova Mongolia e l’effetto della modernizzazione che fa ai personaggi ancorati al passato. A cosa si deve questa decisione di affrontare parallelamente alla storia anche questi argomenti?
I.: Pur non essendo stato esperto di gialli, in Francia c’è una corrente del giallo sociale, che si dice in francese roman noir, che affianca il polar.
Nel polar c’è sempre un detective, un poliziotto e la sua inchiesta.
Nel roman c’è un crimine e a indagare non è sempre un poliziotto, l’importante non è la ricerca di un colpevole, ma di uno sfondo sociale. Io scrivo senza documentazione, quando scrivo mi baso sui miei ricordi di viaggio. Solo dopo vado a verificare se quello che ho scritto è giusto. Come potete vedere, io sono vecchio e ho cominciato a vent’anni – nel periodo hippy – e mi sono abituato a viaggiare a contatto con la popolazione. Questi tre libri sono basati su un viaggio di cinque settimane nel 2008 con mia moglie Francoise e la nostra figlia più giovane, Zoe. Se tu viaggi bene, dopo i primi due giorni capisci tutto appena entri nella Yurta. La cosa più importante è la curiosità che – contrariamente a quanto si pensi – è una cosa positiva.
3. Se dovessero accusarla di appropriazione culturale, da un punto di vista di un occidentale che scrive di un mondo orientale, lei cosa risponderebbe?
I.: Noi europei abbiamo una visione del resto del mondo che conforta i nostri pregiudizi. L’esempio è il nomadismo, pensiamo che siano persone gentili che si spostano da un ambiente all’altro. Invece è una tecnica di sopravvivenza, è un ambiente ostile. Io posso parlare dell’oriente dal mio punto di vista obiettivo, non sono mongolo. Dopo gli attentati contro Charlie Hebdo – alcuni miei amici sono morti, tra l’altro – molti autori hanno fatto degli interventi nelle scuole. Anch’io ho fatto un intervento in una scuola molto vicina al luogo dell’attentato. Il tema era il razzismo e davanti a una cinquantina di ragazzi, ho fatto una domanda: “Chi è razzista, alzi la mano.” E io avevo la mano alzata. Mi hanno guardato tutti come fossi matto. “Sono razzista contro di me, per condizionamento sociale, economico. Ogni volta che lo sono, cerco di correggermi. Ma voi che pensate di non esserlo, non vi ponete neanche la domanda.” Lo stesso è per la Mongolia, è un libro scritto da un occidentale che mi dà la possibilità di esprimere il mio pensiero.
 4. Mi sembra che faccia un gioco con il lettore, mostrando la luce e l’ombra per ogni aspetto. Ce ne vuole parlare?
4. Mi sembra che faccia un gioco con il lettore, mostrando la luce e l’ombra per ogni aspetto. Ce ne vuole parlare?
I.: Come dicevo prima, le cose non sono mai bianche o nere e il modo di scoprirle è lo stesso del viaggiatore. Dietro la bellezza della steppa c’è una vita molto difficile, non sono uno scrittore militante, ma non sono neanche naif. In tutto quello che scrivo cerco di dare entrambe le mie visioni, è un cammino per passare da ammirazione naif a comprensione militante.
5. Cosa pensano in Mongolia dei suoi libri?
I.: Ho avuto circa un centinaio di reazioni e nessuno ha reagito in malo modo. Sono tutti d’accordo con la descrizione del paese, forse non con la conclusione, ma ammettono che i problemi esistono. Chiaramente non è tradotto in Mongolia, ma nel 2019 verrà tradotto in tedesco. In Mongolia si parla quasi dappertutto il tedesco, essendo stati sotto il dominio russo.
6. Perché ha deciso di spostare parte della storia nel mondo occidentale?
I.: La prima è molto materiale: il mio editore francese mi ha chiesto di portare parte della storia in Europa e di portare Yeruldelgger in occidente. Non potevo però giustificare la sua presenza e quindi ho preso altri personaggi per farlo al posto suo. In seconda battuta: Io scrivo senza programmare, non mi fermo finché non arrivo al finale della storia. Solo dopo averla finita torno indietro a rileggere. Nel frattempo, inserisco tutto quello che mi piace. Terzo: a volte ti servono dei motivi per ridare al tuo romanzo la dimensione mondiale. Io non posso parlare della globalizzazione che danneggia la Mongolia senza parlare delle miniere dell’Australia o del Canada.
7. Rétour a Biariz era tra la Francia e il Brasile, Yeruldelgger è tra la Francia e la Mongolia, lei è franco e armeno…
I.: Tutto il mio modo di pensare e di scrivere è legato al fatto che sono il figlio di una diaspora, la più tragica possibile ma culturamente è la cosa più bella che c’è. L’Armenia non aveva territorio ma c’erano partiti politici per eleggere rappresentanti che non avevano un territorio. Il prossimo romanzo che ho consegnato al mio editore francese – che uscirà prossimamente – parla dell’Islanda e ancora una volta è la storia di un autore che torna in Islanda quarant’anni dopo. Siamo quello che la vita ha fatto di noi, la vita ha fatto di me un elemento della diaspora e un viaggiatore, oltre che uno scrittore.
 8. E’ per questo che nel libro si difende tanto la tradizione?
8. E’ per questo che nel libro si difende tanto la tradizione?
Si, perché la tradizione è fondamentale. In Mongolia la tradizione è come il nomadismo, una tecnica di sopravvivenza in un ambiente ostile. La tradizione armena sopravvive ugualmente. Se tu sei a Parigi e senti qualcuno parlare armeno, ci si riunisce subito perché ci si riconosce.
9. Come viaggiava da giovane e perché? Ora è possibile farlo?
I.: Avevo i capelli lunghi, i sandali e giravo in autostop. Da un paese all’altro, usavo l’aereo o lavoravo sulle barche. Ora è difficile. Nel 1969 ho fatto 40.000 km di autostop negli Stati Uniti, quando mia figlia mi ha chiesto di fare lo stesso le ho detto di no!
L’altro romanzo che sta traducendo Fazi – Mato Grosso – racconta delle paludi più grandi del mondo. Io ci sono stato per oltre un anno, nel periodo delle piogge, facendo un sacco di cose stupide, quelle che si fanno a vent’anni. L’altra mia figlia, che vive in Brasile, voleva andare a fare lo stesso giro e ho cercato di convincerla di non andare proprio negli stessi posti che avevo visitato io… Ho scritto un libricino sui viaggi, edito da Ediciclo, “L’arte di perdere tempo”, dove si trova la mia filosofia di viaggi e racconto dove ho incontrato per la prima volta un personaggio di nome Yeruldelgger.
10. Ho letto che sta lavorando a una saga sulla diaspora armena.
Si, ho cominciato a scriverla, dovrebbe uscire per autunno 2019. E’ un lavoro diverso per due motivi: è una storia sui cent’anni dal 1915 al 2015 e poi parte dalla storia vera di mia nonna: nel 1915 ha visto tutta la sua famiglia massacrata. Era parte di una colonia di rifugiati destinata a morire nel deserto della Siria. In Turchia prendevano i civili e li mandavano a morire e mia nonna ha avuto la fortuna che una ragazza turca di Aleppo si stesse per sposare e suo padre cercava delle schiave per lei. Ha preso mia nonna e sua sorella. E’ per questo motivo che sono qui. Genealogia Russia, Europa e America, tre generazioni che non si conoscono, ma alla fine si ritrovano. Lo volevo scrivere nel 2014 perché la mia idea era di sviluppare il romanzo, terminando con qualcosa di geopolitico, l’idea era di finire il libro cento anni dopo all’ONU con un diplomatico turco che faceva un discorso che tutti stavano aspettando: umano e intelligente.
Nel 2014 c’era solo Yeruldelgger da tre mesi e il mio editore francese non era sicuro che ce la facessi a costruire 800 pagine
11. Olivier Truc, scrittore francese come lei, ha scritto tre romanzi sulla Lapponia e sui Sami e, anche nei suoi libri, il territorio è protagonista. Com’è percepita l’integrazione in Mongolia?
I.: Conosco Truc molto bene. Ci sono due differenze importanti: lui è giornalista e sono romanzi molto più documentati dei miei. Il linguaggio è diverso. L’altra differenza è che i Sami stanno cercando di far riconoscere il loro territorio tra la Norvegia, Svezia, Finlandia.
Questo non succede per i Mongoli, sono stati i conquistatori più importanti della storia dell’umanità. Hanno conquistato due terzi della terra abitata, hanno fatto quattro milioni di morti solo con Gengis Khan e quaranta milioni insieme agli altri. Questo vorrebbe dire un massacro, un genocidio. Sarebbe una shoah, è questo Gengis Khan. Sono questi i Mongoli. In più, il nomadismo in Mongolia andrà a morire, resterà solo un nomadismo turistico. I Sami stanno lottando per conservare invece quel tipo di nomadismo.
Intervista a cura di Marco A. Piva
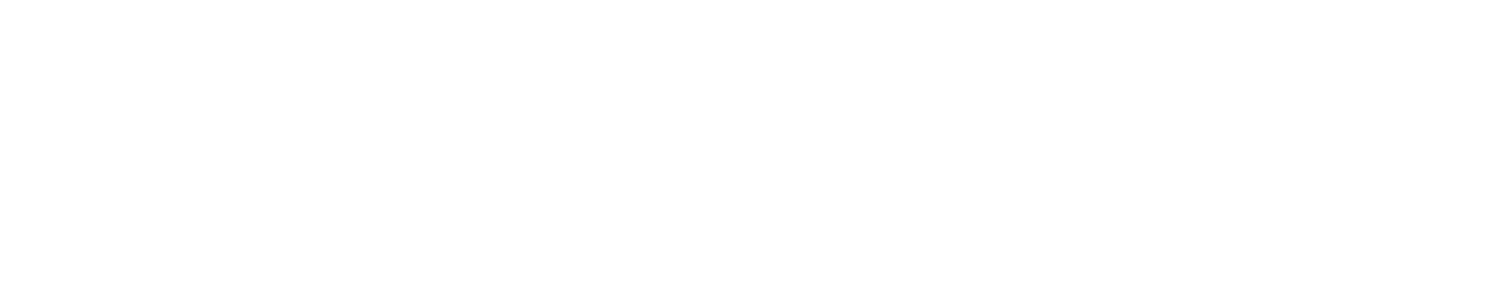













Devi effettuare l'accesso per postare un commento.