Paola Barbato è milanese di nascita, bresciana d’adozione, prestata a Verona dove vive con il compagno, tre figlie e tre cani. Scrittrice e sceneggiatrice di fumetti, tra cui Dylan Dog, ha pubblicato Bilico, Mani nude (vincitore del Premio Scerbanenco), Il filo rosso, Non ti faccio niente e Io so chi sei (il primo titolo di una trilogia). Ha scritto e co-sceneggiato per la Filmmaster la fiction Nel nome del male, con Fabrizio Bentivoglio.
Con Piemme ha pubblicato Non ti faccio niente (2017), Io so chi sei (2018), Bilico (2018), Mani nude (2019), L’ultimo Ospite (2021), Scripta manent (2021), La cattiva strada, (2022).
Sito: www.paolabarbato.it
Sempre per Piemme, è uscito da poco in libreria il suo nuovo romanzo Il dono, del quale troverete la recensione sul blog. Abbiamo intervistato l’autrice per farci raccontare qualcosa di più:
1. Bentornata su Contorni di noir Paola e grazie per la tua disponibilità. La prima domanda è una sorta di rito: da quale idea o spunto è nato questo tuo nuovo romanzo “Il dono”, da qualche settimana in libreria edito da Piemme?
P.: Questa volta non ne ho idea. Ho concepito questo spunto almeno tre anni fa e poi me lo sono inviato via mail. È una cosa che faccio spesso, quando arriva la suggestione me la scrivo da qualche parte, oppure la registro in una nota vocale. Dopo di che, non avendo io una memoria degna di questo nome, la cancello dalla mente, salvo ritrovarla mesi, se non anni, dopo in maniera casuale. Ho anche una cartella nella quale conservo le idee, ma ovviamente dimentico di mettercele.
2. La protagonista, l’ispettrice Flavia Mariani, è una giovane donna rigida nelle sue convinzioni, ligia alle regole, che si muove in un mondo professionale prevalentemente fatto di uomini, e che ha perso una persona alla quale era molto legata. Come la descriveresti a chi ancora non ha letto il romanzo?
P.: Come una persona che non può fermarsi a fare consuntivi sulla sua vita, perché sarebbero in passivo. È sempre stata talmente ferrea nello stabilire razionalmente le proprie priorità, che non si è resa conto che stava trascurando le parti emotive di sé. Quasi tutte le sue scelte sono “pensate” e non “sentite”, quando si arrende all’istinto ne viene trascinata via.
3. Nel libro spunta il dubbio se l’anima di una persona possa restare in una parte del corpo anche dopo la morte. Tu cosa ne pensi al riguardo?
P.: Ci sono moltissime teorie in merito, gran parte della psicometria si basa sul fatto che gli oggetti si carichino delle vibrazioni emotive di chi li possiede, potrebbe essere diversamente con gli organi? Parapsicologia a parte, diverse testimonianze di persone che hanno ricevuto un organo testimoniano di aver avvertito dei cambiamenti in sé, come se la parte trapiantata avesse portato anche un frammento di anima. Io, che sono una persona abbastanza concreta, penso che un organo non sia solo un muscolo o una ghiandola, ma porti in sé tutta una serie di “abitudini”, ritmi, comunicazioni con il resto dell’organismo, che inevitabilmente rimangono.
 4. Ho avuto l’impressione che in queste pagine l’ambientazione fosse più legata alla geografia dei corpi dei personaggi che hanno ricevuto in dono gli organi più che ai posti in cui vivono, nonostante molte sfaccettature sociali legate alle loro vite ne emergano, era tua intenzione e perché?
4. Ho avuto l’impressione che in queste pagine l’ambientazione fosse più legata alla geografia dei corpi dei personaggi che hanno ricevuto in dono gli organi più che ai posti in cui vivono, nonostante molte sfaccettature sociali legate alle loro vite ne emergano, era tua intenzione e perché?
P.: Sì, e c’è stato un momento in cui ho accarezzato l’idea di non dire nemmeno dove si trovassero, esattamente come ho scelto di non dar loro un nome ma di chiamarli con il nome dei loro organi. Dei sette trapiantati la cosa che importa, nella storia, è l’evoluzione della loro psicologia, come vengono influenzati prima dalla malattia e poi dalla guarigione, quanto la loro mente sia recettiva a influenze esterne e come tutti e sette vivano questa ripartenza in maniere opposte.
5. Altra cosa su cui mi sono trovata spesso a riflettere è che nel momento in cui sai una cosa, quella inizia veramente ad esistere e spesso non si può più cancellarla dai pensieri. Un potere in cui la mente sembra comandare il corpo. È sempre così o può succedere anche il contrario di questa situazione?
P.: È un concetto a cui sono legatissima, testimoniato dalla facilità con cui l’evocazione di un’immagine ci obblighi a visualizzarla, senza che riusciamo a impedirlo. È come un’impronta nella coscienza. Tutti i personaggi, e non solo i sette trapiantati, ne sono vittime, il potere di un’idea che si semina nella mente è enorme, non riesci più a prescindere da essa. E se sai manovrarla bene, quell’idea può diventare un’arma.
6. C’è una frase nel libro in cui si afferma che se si ha abbastanza tempo, si possa fare l’abitudine a tutto. Nella tua esperienza personale è così o c’è qualcosa a cui proprio pensi che non potresti fare l’abitudine?
P.: Sono assolutamente certa che l’uomo sia una creatura adattabile. Non stiamo parlando di accettazione ma di abitudine. Ci si abitua a non avere più l’uso delle gambe, alla morte di un figlio, all’esser stati sradicati dalla propria origine, alla violenza, all’assenza di libertà. Ci si abitua a tutto, se si ha abbastanza tempo. Poi che si accetti la nuova condizione è tutt’altro paio di maniche.
7. Se dovessi scegliere un sentimento che più di altri percorre il corpo del romanzo, quale sceglieresti e perché?
P.: Non è un sentimento facile da descrivere, potrei dire “dibattimento interiore” o dicotomia, tutti i personaggi sono spezzati in due e le due parti lottano tra loro. Non c’è tregua.
8. Se puoi, saremmo curiosi di sapere se stai lavorando a un nuovo romanzo, e se puoi darci qualche piccola anticipazione.
P.: Ho iniziato a lavorarci da qualche settimana e si prospetta come un libro diversissimo da tutti gli altri, che ha per protagonisti un padre e un figlio con un insanabile conflitto. Ma è ancora tutto in formazione.
Intervista a cura di Federica Politi
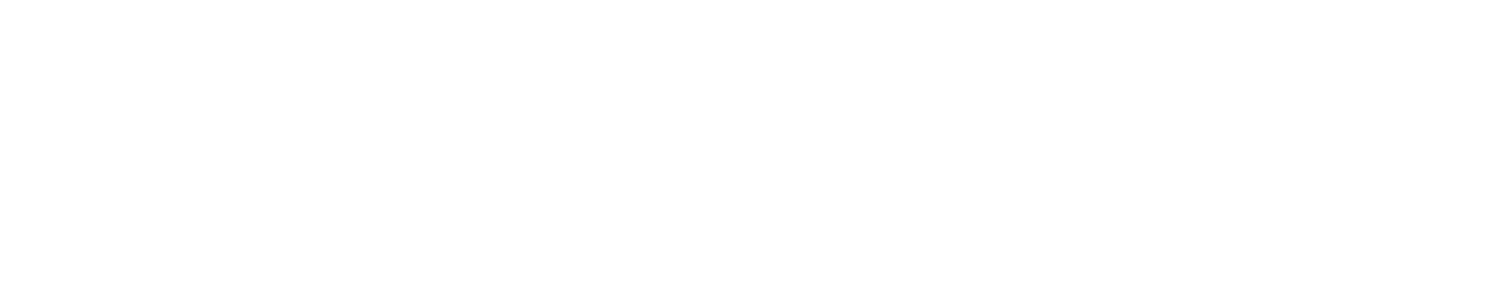














Devi effettuare l'accesso per postare un commento.